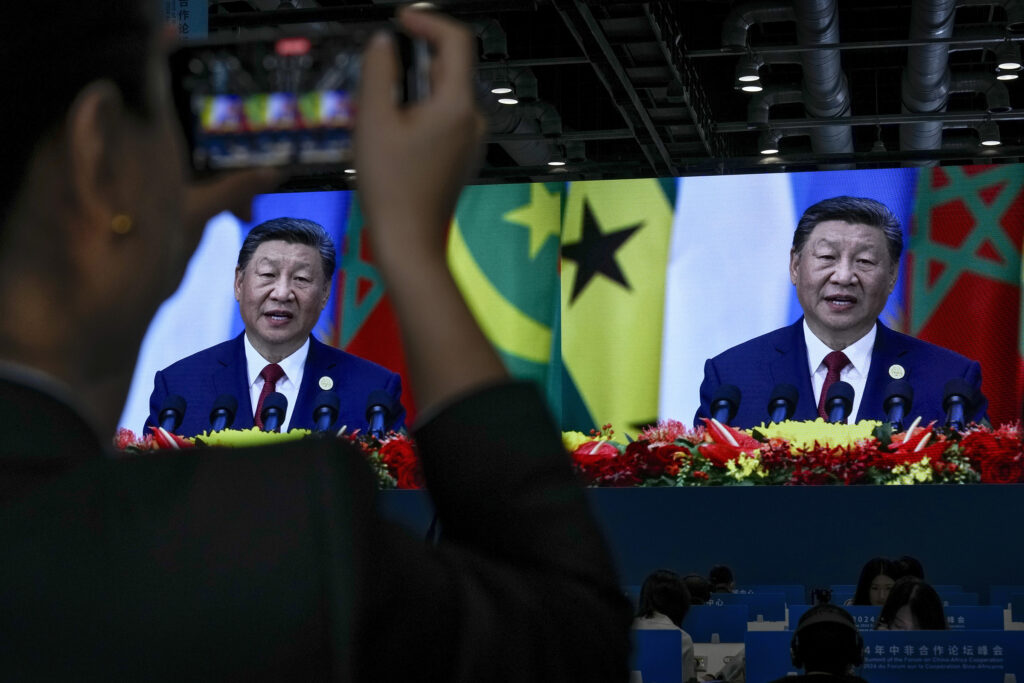INTERVISTA – La presenza in Italia dei Fratelli Musulmani e la questione dell’integrazione. Ne parliamo con Souad Sbai, già deputato e presidente di ACMID Donna Onlus.
Sbai spiega che “A partire dagli anni Sessanta, la presenza dei Fratelli Musulmani in Europa non è più un mistero. Il movimento si è progressivamente inserito nel tessuto sociale di diversi Paesi. In Italia è riuscito a costruire una struttura solida, partendo dalla Grande Moschea di Roma per espandersi verso nord, in particolare a Milano, Torino (considerata il loro principale bastione), Brescia, Parma e altre città.
Il loro radicamento risale alla fine degli anni Sessanta, quando un piccolo gruppo di studenti, per lo più originari di Siria, Giordania e Palestina, fondò l’”Unione degli studenti musulmani in Italia” (USMI). Ben presto associazioni caritative provenienti dal Medio Oriente divennero importanti sostenitori finanziari: in tre anni avrebbero investito 25 milioni di euro per costruire 43 moschee, tra cui quelle di Ravenna, Catania e Piacenza, o per acquistare un edificio nel quartiere romano di Centocelle, destinato a sostituire la Grande Moschea di Roma, ritenuta ostile alle idee dei Fratelli Musulmani. Queste informazioni provengono da un’inchiesta dei giornalisti francesi Christian Chesnot e Georges Malbrunot.
Oggi l’Unione delle organizzazioni e comunità islamiche in Italia, creata negli anni Noanta e guidata dal siriano Mohammed Nour Dachan, svolge il ruolo di rappresentante ufficiale del movimento. Riunisce circa 130 associazioni, controlla quasi l’80% delle moschee del Paese e dispone di ramificazioni culturali e sezioni giovanili.
La confraternita punta sulle reti di migranti e rifugiati recenti per ampliare le proprie attività. La sua influenza è cresciuta notevolmente dalla seconda metà del XX secolo, secondo uno studio del Centro europeo di studi sulla lotta al terrorismo e all’intelligence. L’organizzazione mette in atto quelle che definisce “strutture parallele”, concepite come sostituti dello Stato e della società. Obiettivo: influenzare le decisioni politiche in Europa per promuovere le proprie rivendicazioni. Questa strategia ha contribuito a radicare i suoi valori in alcune comunità, al prezzo di un’erosione delle identità locali e della rottura con alcune norme europee.
Secondo lo studio, il fenomeno modifica persino la composizione demografica e favorisce l’emergere di nuove minacce: l’ascesa dell’estrema destra come reazione, la moltiplicazione di enclavi comunitarie isolate dai valori europei e il rifiuto dell’”integrazione” nel tessuto sociale.
L’influenza dei Fratelli Musulmani in Italia non si limita al territorio nazionale. Essi giocano un ruolo attivo anche in diversi network europei, come l’Unione delle organizzazioni musulmane o l’Organizzazione del Waqf islamico. Alcune figure occupano posizioni chiave a livello continentale, come il giordano Ali Abu Shwaima, presente in numerose strutture italiane ed europee legate al movimento.
Nel 2022 il sito European Eye on Radicalization pubblicò uno studio che evidenziava legami considerati “preoccupanti” tra alcune strutture vicine ai Fratelli Musulmani in Italia e organizzazioni sciite iraniane. Secondo questa analisi, nonostante le rivalità storiche tra sunniti e sciiti, possono formarsi alleanze occasionali in nome di obiettivi comuni: opposizione all’occidente, ostilità verso Israele o promozione di uno Stato fondato sulla sharia.
Il rapporto raccomandava alle autorità italiane di rimanere vigili di fronte a qualsiasi segnale di ricostituzione di tali alleanze a livello locale, a causa del rischio di radicalizzazione comunitaria e di infiltrazione istituzionale, potenzialmente minaccioso per la democrazia liberale.
Altri studi sottolineano che oltre due milioni di musulmani in Italia vivrebbero oggi una fase difficile, a causa della dominazione dei Fratelli Musulmani sui luoghi di culto. Il problema, ricordano, non risiede nel numero di musulmani in Europa, ma nell’ideologia estremista diffusa dall’organizzazione, che alimenta violenza e radicalizzazione.
La rete si estende ben oltre i confini italiani. In diversi Paesi europei la guerra di Gaza ha aggravato due rischi: da un lato il rafforzamento dell’influenza dei Fratelli Musulmani su grandi centri islamici; dall’altro l’ascesa dei movimenti di estrema destra, le cui azioni ostili colpiscono spesso le minoranze, in particolare quella musulmana.
Per la politologa Akila Dbeich, direttrice del Centro francese di studi strategici e internazionali, è urgente rafforzare l’integrazione dei musulmani all’interno della società europea, al fine di limitare le fratture e contrastare i tentativi di reclutamento dei giovani da parte dei Fratelli Musulmani, che sfruttano sia la situazione a Gaza sia gli atti discriminatori dell’estrema destra.
In Svizzera la questione sta assumendo maggiore rilevanza. Un rapporto francese pubblicato nel maggio 2025, che menzionava i pericoli dell’espansione dei Fratelli Musulmani per la coesione sociale, ha puntato i riflettori sulla Confederazione. Secondo il quotidiano 24 Heures, l’influenza del movimento va oltre l’ambito religioso: si esercita discretamente attraverso reti educative, finanziarie e comunitarie, costituendo così una minaccia diffusa per i valori democratici.
Il documento francese ha suscitato un acceso dibattito al Parlamento federale svizzero. La deputata Jacqueline de Quattro (PLR, cantone Vaud) ha richiesto un rapporto dettagliato sulla presenza, l’organizzazione e i mezzi d’azione dei movimenti islamisti politici nel Paese, in particolare di quelli vicini ai Fratelli Musulmani. La sua proposta gode di un ampio sostegno, che va dai Liberali-Radicali al Partito Popolare Svizzero, passando per il Centro e i Verdi Liberali.
Le preoccupazioni non sono nuove. Già nel dicembre 2021 un progetto di legge promosso dal deputato Lorenzo Quadri mirava a criminalizzare l’”Islam politico”, vietare le associazioni che difendono tale ideologia e chiudere le loro moschee. A seguire altri parlamentari, come Doris Fiala o Ruth Humbel, hanno proposto di vietare qualsiasi finanziamento estero a queste associazioni, mentre Walter Wobmann ha presentato un’interpellanza sullo stesso tema”.